Blog La scelta della Fondazione Sciascia di dialogare con gli studenti siciliani sul Candido mi pare necessaria. Il "Candido, ovvero Un sogno fatto in Sicilia", geniale capriccio dello scrittore di Racalmuto, scioglie la metafora voltairiana e ne verifica l’attualità: non è la fuga astiosa nel privato ma la capacità di consegnarsi, con intatta disponibilità ma senz’ombra d’illusioni, al presente e ai suoi fallibili progetti
In questi tempi tristi di pandemia, come ai tempi della peste manzoniana pullulanti di imposture e impostori, di don Ferrante e Azzeccagarbugli negazionisti e riduzionisti, di fake news e cacce all’untore, la scelta della Fondazione Sciascia di dialogare con gli studenti siciliani, quest’anno, proprio sul Candido, ancorché dettata dal caso mi pare segretamente ispirata dalla necessità. Quel Candido, ovvero un sogno fatto in Sicilia, quel geniale capriccio concepito nel 1977 dallo scrittore di Racalmuto, esibisce infatti, oggi come ieri, la sua intatta attualità.
Attualità sorprendente di questa come delle altre opere di Sciascia: e non solo dei gialli di mafia o di quelli metafisici, delle indagini d’archivio o di certe complicate affaires: anche di piccoli capolavori d’inusuale leggerezza («ma greve è il nostro tempo, assai greve», avvertiva Sciascia nella nota finale) come questo Candido, che si insinua come un movimento di allegretto tra l’andante maestoso di Todo modo e l’adagio da requiem dell’Affaire Moro.

La prima edizione, Einaudi 1977, di “Candido ovvero Un sogno fatto in Sicilia” di Leonardo Sciascia
E in una narrazione agile e felice, di grazia settecentesca, incastra compendiose riflessioni e aforismi taglienti: sulla chiesa cattolica e sul partito comunista, su fascismo e antifascismo, sulla realtà della Sicilia e sul mito di Parigi, sulla verità e sulle imposture (tutte, da certo miracolismo cattolico – le straordinarie pagine su Lourdes – alla dogmatica marxista); e ci regala perfino le sole pagine sciasciane di franco e gaio erotismo (che in un libro “libertino”, modellato su Voltaire, non potevano mancare, come a dirci dello scrittore votato alla “leggerezza” e al diletto che Sciascia avrebbe voluto essere – e non potè).
La vicenda di Candido Munafò, nato in una grotta sotto i bombardamenti, si snoda come l’autobiografia di una nazione, a partire da quella nascita prodigiosa e da quel nome immacolato, aurorale: come la nuova Italia che avrebbe dovuto nascere, in un’aura di miracolo, dalle macerie del fascismo. Abbandonato dalla madre e orfano del padre, orfano Candido è per natura e vocazione: orfano di chimere e pregiudizi, di fedi e interessi, di appartenenze e connivenze. E con occhi precocemente smagati osserva, perciò, i trasformistici equilibrismi di un’intera classe dirigente all’indomani della liberazione, la speculare e omertosa grettezza degli intrallazzi democristiani e della Realpolitik comunista, le superstizioni bigotte e i fideismi ideologici che ottenebrarono gli anni ’50 e ’60.
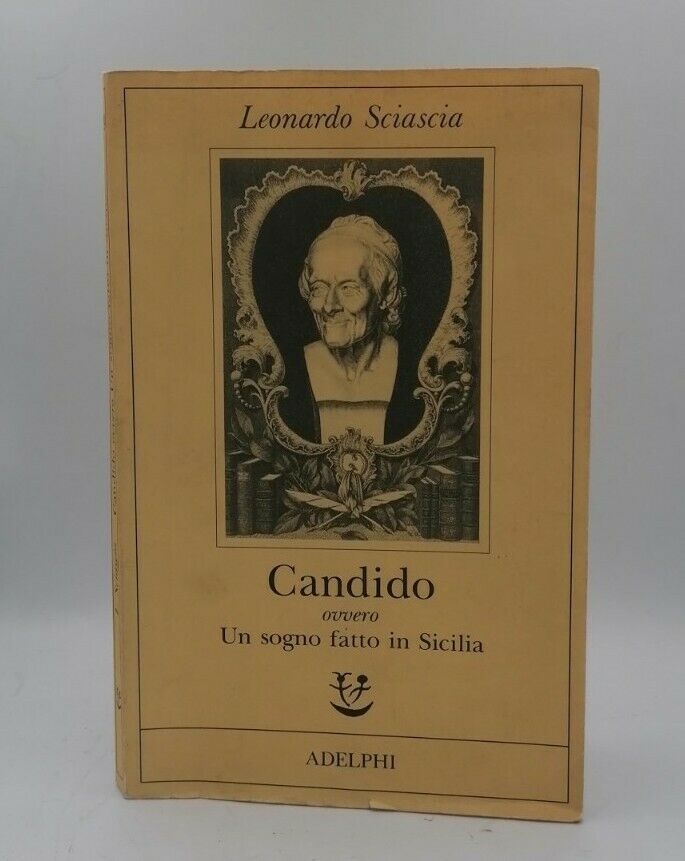
La seconda edizione, Adelphi 1990, del “Candido” di Sciascia
Attraverso queste stazioni si muove – con picaresca allegria e incontaminato “candore” – il viaggio nel peggiore dei mondi possibili di questo Candido post-voltairiano, di quest’intellettuale inorganico a tutte le fedi. Inorganico fu Sciascia, anzitutto, rispetto a se stesso, alle sue convinzioni, ai suoi idoli (congedati, l’amato Voltaire in primo luogo, nell’ultima memorabile pagina), pronto com’era a “contraddire” ma anche a “contraddirsi”: è questo il significato di una traiettoria che dal sontuoso concerto del Consiglio d’Egitto alla stilizzata palinodia del Candido (e infine ai derisori “ragazzi dell’89” de Il cavaliere e la morte) implica ab initio e racconta senza sviluppi preludio e fine dell’illuminismo.
Quei movimenti e raggruppamenti che sempre più distrattamente ne custodiscono la vacillante fiamma rischiaratrice sembrano allo Sciascia di Candido minacciati dall’efficienza priva d’idee dei nuovi tartufi alla Fomà Fomìc: e si legga il gustoso episodio del funzionario comunista alle prese col nomignolo dostoevskijano affibbiatogli da Candido. E le istituzioni, le iniziative e i progetti in cui quella luce stancamente occhieggia gli appaiono simili al treno per Lourdes che attraversa il capitolo forse più significativo del romanzo: una corte dei miracoli in cui può accadere di tutto fuorché il miracolo di una palingenesi.

Leonardo Sciascia
Già il Candido di Voltaire aveva scoperto quali atrocità si celassero nel “migliore dei mondi possibili”; e aveva compiuto la sua scelta: «il faut cultiver notre jardin». Il Candido di Sciascia scioglie la metafora voltairiana e ne verifica l’attualità: non è la fuga astiosa e rinunciataria nel privato ma la capacità di consegnarsi, con intatta disponibilità ma senz’ombra d’illusioni, al presente e ai suoi fragili e fallibili progetti, da abitare con la ritrosa diffidenza di chi sa dubitare e contraddire, e con la vigile consapevolezza «che qualcosa sta per finire e qualcosa sta per cominciare».
E qualcosa stava davvero per cominciare, in quei tardi anni ’70 in cui Sciascia scriveva il suo Candido; ma qualcosa di ben peggio di quanto Sciascia potesse allora immaginare o addirittura sperare (chi l’ha detto che Sciascia non coltivasse la speranza, «la silenziosa fragile speranza dei siciliani migliori»?): una degenerazione antropologica, una devastazione di idealità e valori, un’avvilente omologazione che il suo amico Pasolini aveva già previsto e di cui l’ultimo Sciascia prenderà tristemente atto, soprattutto ne Il cavaliere e la morte, dove il suo Vice avvertirà che «la moneta del vivere ogni giorno perdeva di valore; la vita intera era una specie di vacua euforia monetaria senza alcun potere di acquisto».










Commenti